Il merito di un libretto frettoloso, assertivo e non particolarmente meditato qual è Insegnare l’Italia. Una proposta per la scuola dell’obbligo, di Ernesto Galli della Loggia e Loredana Perla (Scholé, 2023) risiede nel fatto di offrirsi ai lettori, nella sua schiettezza quasi brutale, come una sorta di manifesto ideologico di ciò che la destra nazionale e, più in generale, l’area culturale alla quale essa fa riferimento, medita sulla scuola italiana e intende mettere in atto. Ma non solo. Come è risaputo, infatti, gli autori fanno parte della «Commissione di studio composta da esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale con l’obiettivo di elaborare e formulare proposte volte alla revisione delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida relative al primo e al secondo ciclo di istruzione»: Perla, docente di Didattica e pedagogia speciale presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, della Commissione ne è la coordinatrice, mentre Galli della Loggia è il componente designato a sovraintendere la sezione sull’insegnamento della storia.
Le Linee guida per la primaria e la secondaria sono state da poco tempo esitate, dopo una sapiente campagna preparatoria, fatta di annunci, anticipazioni, interviste rilasciate dal Ministro Valditara e dalla stessa Professoressa Perla. Galli della Loggia, d’altro canto, aveva consegnato qualche anno fa a un altro libro, L’aula vuota. Come l’Italia ha distrutto la sua scuola (Marsilio, 2019), oltre che a numerosi editoriali, le sue idee sull’istruzione e il suo vagheggiamento di una “riforma” che facesse piazza pulita di almeno mezzo secolo di innovazione didattica.
Il dibattito è in corso, e si spera che duri più del tempo di una coda polemica su un provvedimento legislativo: perché, con tutta evidenza, si tratta di qualcosa di più di una notizia da commentare per il tempo effimero che concede l’attualità da social. Doppiozero sta già ospitando contributi di specialisti che stanno intervenendo sulle parti disciplinari delle indicazioni: chi scrive qui non ha adeguate competenze per farlo; nondimeno, mi pare che valga la pena provare a formulare qualche altra riflessione a corredo. Sebbene le sezioni delle Nuove Indicazioni Nazionali relative alle singole discipline siano piuttosto eterogenee e in alcuni casi apparentemente contraddittorie (deliberatamente ideologica quella sulla Storia, ad esempio; quasi scelleratamente scanzonata quella sulla Letteratura, nella quale, oltretutto, l’«l’obbligo assegnato alla scuola di adeguarsi a ciò che piace e vuole la società», deprecato nel saggio dello storico romano, viene eletto quasi a paradigma metodologico nella scelta dei testi), la cornice culturale e politica che li racchiude è sconsolatamente chiara e coerente. E proprio la lettura di Insegnare l’Italia. Una proposta per la scuola dell’obbligo la definisce ancora meglio. Volendo essere brutalmente apodittici, si può dire che il progetto di scuola licenziato dalla commissione governativa sia imperniato su due imperativi categorici: smantellare l’idea stessa di scuola democratica, aperta, inclusiva che si è provato a realizzare negli ultimi decenni, per tornare a modelli antecedenti al Sessantotto e a una stagione «che ha lasciato in eredità ai suoi posteri mille e una mela avvelenata»; far sì che i programmi abbiano «come asse l’identità italiana, i suoi caratteri e tutto ciò che in essa si sostanzia», giacché bambini e adolescenti devono «essere pensati come italiani» (il ricorso al maschile estensivo, tanto in questo testo che nelle Indicazioni, più che una spia linguistica, deve essere una deliberata reazione a quello che, nell’Introduzione, viene chiamato «il veleno del politicamente corretto»). Non deve certo stupire, a questo punto, che la nozione di “identità italiana” (e, pur meno frequentemente, di “Occidente” e identità occidentale) venga data per scontata e in nessun modo problematizzata: nella migliore delle ipotesi definita assai sbrigativamente o, peggio, tautologicamente («L’identità italiana non è altro che l’Italia»). A questa osservazione si potrebbe obbiettare che, per approfondire la questione, o meglio per comprenderne meglio il significato politico, esiste già la ricca bibliografia del professore, da L’identità italiana a Pensare l’Italia: andrà detto che, rispetto al disegno del ministro e del governo, non avrebbe potuto esserci designazione migliore. Nondimeno, non si può non restare allibiti nel constatare che operazioni di tale sorta vengano riproposte con tale disinvoltura – la quale, non potendo essere imputabile ad ingenuità, non può che essere considerata un ulteriore gesto di tracotanza –, da non tenere in alcun conto una messe ormai significativa di studi sulle “invenzioni della tradizione”, inclusa quella italiana.
E in effetti, come è stato notato (da Antonio Viglilante) la scelta dell’illustrazione di copertina restituisce icasticamente il senso complessivo della proposta di Galli della Loggia e Perla: un’opera tardocinquecentesca di Vincenzo Rustici che rappresenta la sfilata delle contrade in piazza del Campo a Siena (per altro non indicata dagli autori e dall’editore): municipalismo, tradizione, appartenenza, italiana o occidentale che sia.
Ma se, per varie ragioni (non ultima l’esordio provocatorio del paragrafo sulla storia delle NIE) questi orientamenti sono stati oggetto di polemiche e dissensi, non sono meno significative le posizioni sull’insegnamento della letteratura, specie alla primaria, e sulla lettura dei testi. Il sentimento di stupore, venato di una certa inquietudine, si rinnova infatti leggendo i capitoli III e IV del libretto, quelli redatti da Perla. In effetti, riflettendo più cautamente (e malinconicamente) non ci sarebbe ragione di stupirsi, finanche perfino di indignarsi, per gli usi politici della letteratura (“giusti e sbagliati” che siano, come avrebbe detto Calvino): più che di qualsivoglia altro catalogo dell’immaginario, della tradizione letteraria italiana si è sistematicamente abusato, per farne un paradigma identitario nazionale e un grande repertorio di italianità sul quale formare generazioni di studenti. Le interpretazioni forzose e tendenziose dei classici, oltretutto, piuttosto che fornire spunti esegetici degni di questo nome sulle opere stesse, hanno sempre offerto, semmai, indicazioni preziose, quando non rivelatrici, su quale fosse la visione del modo e delle cose di chi se ne è servito, dal Risorgimento al Fascismo alla Repubblica; ma si potrebbe facilmente risalire ancora a secoli precedenti, finanche alla polemica di Orsi e Muratori, all’inizio del Settecento, contro l’Accademia di Francia, la quale rivendicava di avere guadagnato il primato europeo nella letteratura – e quindi, in quella prospettiva, mondiale –, scalzando dal podio proprio l’Italia, la cui lingua era per giunta effeminata. Come si vede, insomma, si tratta di una vecchia storia, intrisa di nazionalismo e di virilizzazione della cultura; semmai c’è da preoccuparsi per il fatto che tiri di nuovo questa aria piuttosto mefitica (come ha dimostrato l’incredibile discorso di Roberto Vecchioni il 15 marzo scorso in occasione della manifestazione a sostegno dell’Europa: di nuovo la letteratura usata per distinguere “noi” da “loro”).
Per suffragare la proposta pedagogica destinata a bambini e adolescenti sull’insegnamento della identità italiana: della sua storia, della sua geografia, della sua cultura, Loredana Perla, nei suoi capitoli, ricorre a due classici della narrativa per ragazzi del secondo Ottocento: Cuore e Le avventure di Pinocchio, da riportare perentoriamente nelle aule scolastiche. Come ci si poteva aspettare, dai due romanzi la pedagogista ricava un florilegio di spunti e suggestioni a sostegno delle sue tesi: l’istruzione come apprendimento dell’italianità (“Cuore è un dispositivo didattico perfetto per insegnare le “coordinate di popolo”, quelle che ogni bimbo o bimba italiani dovrebbero in interiore homine maturare”), il ripristino dell’autorità genitoriale (paterna, per lo più) e magistrale, la rimozione delle differenze (di classe, di genere…), la liquidazione della pedagogia “sessantottina”, come si è detto.
Sarebbe troppo facile e scontato criticare De Amicis accodandosi a una lunga lista di autorevoli denigratori (da Eco ad Arbasino, da Natalia Ginzburg a Paolo Poli), o evidenziarne l’anacronismo (nondimeno non si può non rilevare come venga ignorata, dalla studiosa, una più recente produzione di narrativa per ragazzi di altissimo livello). Ci pare più interessante, semmai, rovesciare l’assunto da cui muove Perla, come ha fatto Marcello Fois in L’invenzione degli italiani. Dove ci porta Cuore (che l’autrice cita, ma sembra avere letto distrattamente): non solo perché da quel paternalismo umanitario e ingenuamente irenico, “irrigidito in una retorica, in un sentimentalismo ricattatorio” (per citare un altro elogio di Cuore, quello di Filippo La Porta, anch’esso distantissimo dalle tesi del libro), da quella fiducia incondizionata per la nuova Italia, De Amicis si sarebbe affrancato pochi anni dopo, aderendo al Partito socialista e spostandosi su posizioni più radicali e conflittuali. Ma, appunto, perché perfino il suo romanzo più celebre potrebbe essere riletto come un viatico per una scuola dell’inclusione, addirittura antesignana di quell’universalismo cosmopolita tanto deprecato da della Loggia e Perla. Il muratorino che «sa fare il muso di lepre» anticipa il famigerato Cardini dei romanzi Ex cattedra e Sottobanco di Starnone e del film La scuola che ne ha tratto Daniele Luchetti, il cui unico talento è fare bene la mosca (e a questo si appiglia, per provare a salvarlo, il professor Vivaldi, campione di quella idea di scuola che gli autori vorrebbero spazzare via); il ragazzo calabrese che si è aggregato alla classe viene accolto con queste parole dal maestro Perboni: «Vogliate bene al vostro fratello venuto da lontano [...] Fategli vedere che un ragazzo italiano, in qualunque scuola italiana mette il piede, ci trova dei fratelli»: facile immaginare chi possa essere, nella scuola dell’obbligo del 2024, lo scolaro «dal viso molto bruno, coi capelli neri, con gli occhi grandi e neri, con le sopracciglia folte e raggiunte sulla fronte; tutto vestito di scuro», italiano come i suoi compagni, a dispetto degli inaccettabili ritardi della legislazione italiana. Nondimeno, nel progetto di costoro, dove la famiglia sembra essere l’unica altra agenzia educativa oltre alla scuola, e la sfiducia nell’autonomia cognitiva delle bambine e dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti appare desolante, il vero eroe di Cuore sembra essere l’ingegner Bottini, il papà di Enrico: quello che scriveva sulle pagine del diario di quella povera creatura (solitamente si trattava di reprimende sabaude); che lo leggesse anche, dunque, era scontato: mettere il naso nelle carte private di un ragazzino non poneva ancora alcuno scrupolo a due genitori borghesi della Torino dell’A.S. 1881-82. Ma forse nemmeno oggi.
“Eccellenza”, lemma prevedibilmente assai ricorrente in Insegnare l’Italia, è il modo in cui Pinocchio appella Mangiafuoco, per blandirlo e convincerlo a non fare di Arlecchino legna da ardere. Le chiavi interpretative del capolavoro collodiano che lo rendono irriducibile a una pedagogia nazionalista di tale sorta sono così numerose (oltre che ovvie) che è impossibile riassumerle qui: l’irrisione verso le figure della legge e del potere costituito (i gendarmi, il giudice scimmione, l’imperatore di Acchiappacitrulli); la crudeltà degli adulti nell’esercizio delle loro funzioni (il domatore di asinelli del circo, il proprietario del campo dove Pinocchio ruba l’uva, l’ortolano che come salario gli dà un bicchiere di latte); adulti che oltretutto si rivelano assai più frequentemente infingardi e mentitori di quanto non lo sia il burattino (la Volpe e il Gatto, l’Omino di burro); il maternage di Geppetto in una famiglia monogenitoriale e non-naturale... Non meno cospicua è la bibliografia critica che lo affranca da corrive letture edificanti. Ci basti qui solo una notazione di Daniela Marcheschi: il punto esclamativo seguito dalla reticenza dell’ultima battuta del racconto («Com’ero buffo, quand’ero un burattino! E come ora son contento di esser diventato un ragazzino perbene!...», dice Pinocchio «dentro di sé con grandissima compiacenza») sono il varco testuale che l’umorista Collodi apre, con ironia e cercando la complicità del lettore, per lasciare fuggire il suo puer, affinché si sottragga al conformismo dei grandi e conservi la libertà e la vitalità, la curiosità e l’irriverenza dell’infanzia.
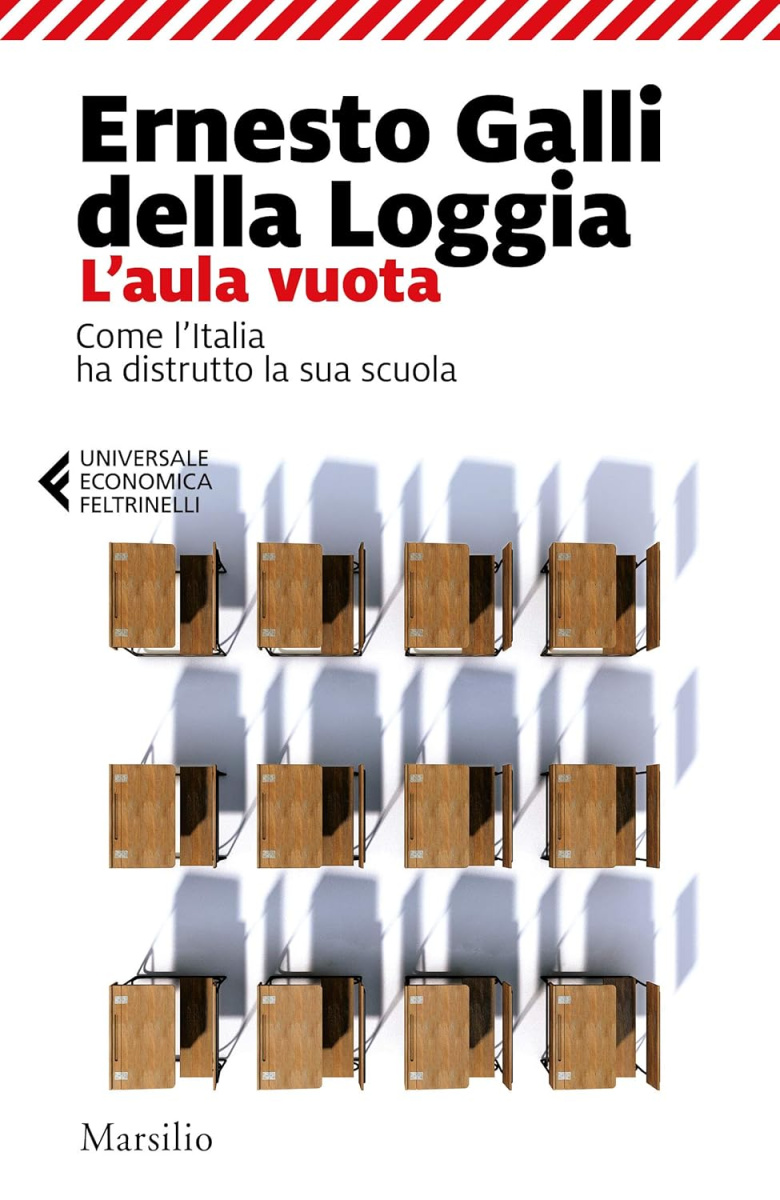
Nessun commento:
Posta un commento